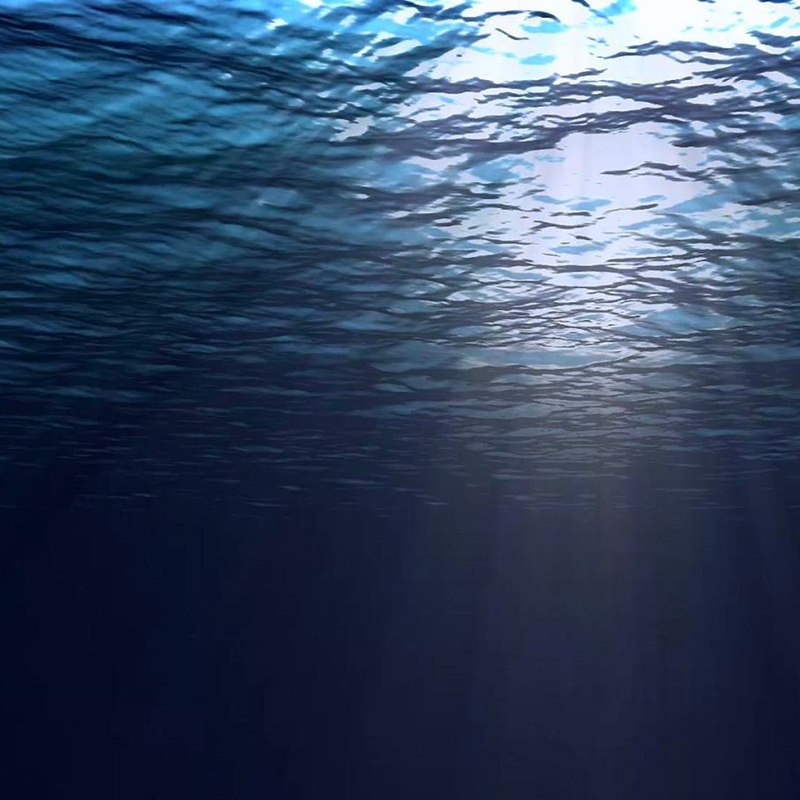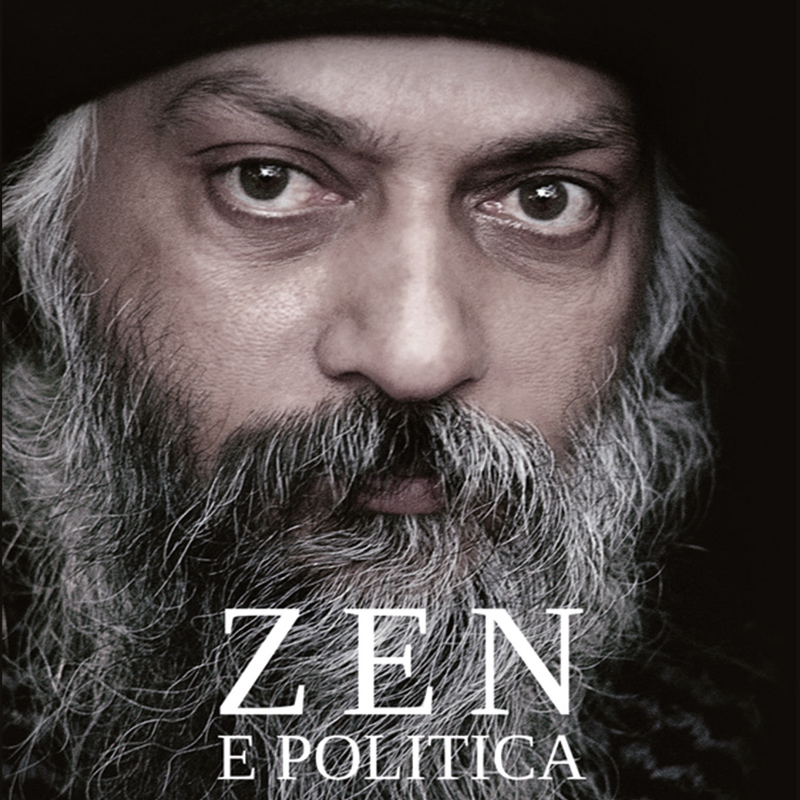Un’altra TienAnmen emergenza Birmania
 Mentre sto scrivendo queste righe (3 ottobre 2007), la salma del giornalista giapponese Kenji Nagai fa il suo mesto ritorno all’aereoporto Narita di Tokyo per essere presa in consegna dalla famiglia. Il 28 settembre una pallottola sparatagli a bruciapelo da un soldato birmano, aveva letteralmente spappolato il cuore del cinquantenne video-cronista della APF News che stava filmando e fotografando la brutale repressione di una manifestazione di protesta nei pressi della Sule Pagoda di Rangoon (Yangoon).
Mentre sto scrivendo queste righe (3 ottobre 2007), la salma del giornalista giapponese Kenji Nagai fa il suo mesto ritorno all’aereoporto Narita di Tokyo per essere presa in consegna dalla famiglia. Il 28 settembre una pallottola sparatagli a bruciapelo da un soldato birmano, aveva letteralmente spappolato il cuore del cinquantenne video-cronista della APF News che stava filmando e fotografando la brutale repressione di una manifestazione di protesta nei pressi della Sule Pagoda di Rangoon (Yangoon).
Kenjii Nagai è una delle decine, forse centinaia, di vittime di due settimane di manifestazioni e cortei contro la giunta militare che governa da decenni con pugno di ferro la Repubblica di Myanmar (l’antica Birmania così ribattezzata dai generali in segno tangibile di rottura con il passato coloniale della regione).
Paese di 55 milioni di abitanti, nella quasi totalità buddisti, la Birmania è una delle nazioni più povere dell’Asia. Gran parte della popolazione vive in condizioni economiche drammatiche con l’equivalente di meno di 50 centesimi di euro al giorno e le politiche governative l’hanno tenuta sigillata dal resto del mondo e impermeabile al miracolo economico di cui beneficiano da decenni grandi e piccole nazioni dell’area. Lo stesso turismo è soggetto ad una disciplina piuttosto stretta che ne regola severamente i flussi.
Dopo una lunga serie di guerre, nel 1886 la Birmania venne definitivamente conquistata dall’Inghilterra ed entrò a far parte dell’India britannica. Nel 1937 ne uscì e, dopo essere stato uno dei principali teatri bellici della seconda guerra mondiale (invasa dai giapponesi nel 1942 e riconquistata dagli Alleati nel 1945 con l’aiuto determinante del movimento di resistenza antifascista AFPFL guidato da Aung San, che sarà poi assassinato nel luglio 1947 da rivali politici), la Birmania diventerà una repubblica indipendente il 4 gennaio 1948.
Per poco più di una decina di anni ebbe una serie di governi democratici, nonostante fortissime tensioni interne causate in particolare dalle richieste di sempre maggiori autonomie da parte delle numerose minoranze interne. E nel 1961 fu proprio un birmano, U Thant, a diventare il primo segretario generale non occidentale dell’ONU. Ma nel 1962 un colpo di stato militare guidato dal generale Ne Win sciolse il governo e si insediò al potere instaurando un regime dittatoriale e marxista che, in nome di una fantomatica “via birmana al socialismo”, produsse danni terribili al tessuto economico e sociale della nazione. Collettivizzazioni e nazionalizzazioni, abolizione del libero scambio, messa fuori legge dei partiti politici si accompagnarono a feroci ondate di repressioni politiche e fecero calare sulla Birmania le ombre di una cupa notte autoritaria.
Nel 1988 dopo una serie di rivolte studentesche a cui aveva aderito gran parte della popolazione inclusa l’ influente e numerosa (circa 600.000 persone) comunità monastica, Ne Win fu costretto a dimettersi e gli subentrò il generale Saw Maung. Questi promise libere elezioni che, per la prima volta dopo oltre vent’anni, si tennero nel 1990 e videro una forte affermazione della LND (Lega Nazionale per la Democrazia), il movimento guidato da Aung San Suu Kyi, figlia di Aung San. Con 392 seggi su 485 era ampiamente in grado di governare il paese ma i militari non accettarono il verdetto delle urne e diedero vita ad un altro golpe, dichiarando nullo il risultato elettorale e procedendo a una massiccia ondata di arresti che portò in carcere i principali esponenti politici, in primis Aung San Suu Kyi, che venne poi insignita nel 1991 del Premio Nobel per la Pace ed è oggi unanimemente considerata l’esponente principale dell’opposizione al regime.
Il 24 aprile del 1992 diviene capo di stato il generale Than Shwe l’uomo forte della giunta spesso definito una sorta di ibrido, metà Pol Pot e metà Pinochet. La vita per la popolazione è sempre più difficile ma il regime si compiace di una serie di misure demagogiche. Come si è già detto, in un sussulto di retorica anti imperialistica l’antico nome di Birmania (Burma in inglese) viene cambiato in quello di Myanmar. Si costruisce, nei pressi dell’antica Yangoon, la nuova capitale Naypyidaw (letteralmente “la sede dei sovrani”) e, soprattutto, si rinsaldano gli storici legami politici ed economici con la Cina comunista che diviene il grande protettore della nuova Birmania e della sua giunta di militari golpisti. Ma nemmeno questo, riesce a migliorare la qualità della vita della popolazione che patisce la guida di uno dei regimi più inetti, rapaci e corrotti dell’intero sud est asiatico. E mentre una serie di monsoni più violenti del solito si abbatte su ampie zone del paese devastandole senza che alcun aiuto venga dal governo centrale, su Internet circolano le immagini clandestine dello sfarzoso e opulento matrimonio della figlia del generale satrapo Than Shwe.
E quando negli scorsi mesi l’aumento del combustibile si riverbera sui costi facendo lievitare all’improvviso i prezzi di tutti i generi di prima necessità, verso la fine di agosto cominciano le proteste.
“Inizialmente le piccole, spontanee, manifestazioni erano guidate da sparuti gruppi di militanti dell’opposizione democratica ancora a piede libero e coinvolgevano poche centinaia di residenti a Rangoon” ci spiega Claudio Tecchio, coordinatore della Campagna di Solidarietà con il Popolo Tibetano della CISL, che sta seguendo da vicino quanto succede in Birmania, “La svolta si è verificata dopo l’aggressione subita da un gruppo di monaci che si erano uniti alla popolazione per manifestare contro il carovita. Alcuni religiosi avevano infatti subito un vero e proprio pestaggio ed il loro abate aveva prontamente chiesto le scuse ufficiali ai responsabili dell’aggressione. Scuse tardive e nuove minacce hanno quindi scatenato l’ira della locale comunità monastica che ha preso d’assalto, tra gli applausi della popolazione, i mezzi militari con i quali i gerarchi erano giunti alla pagoda. Da quel momento la protesta si è estesa a tutti i principali monasteri e la comunità monastica ha assunto la direzione politica del movimento organizzando imponenti manifestazioni in tutte le città birmane. Si è persino costituita una Alleanza di Tutti i Monaci Buddisti Birmani con lo scopo dichiarato di coordinare la protesta e delegittimare alcuni religiosi collaborazionisti che si arrogavano il diritto di parlare a nome del Shanga [la comunità monastica] birmano”.
Il resto lo abbiamo visto sugli schermi televisivi e letto sulle prime pagine di tutti i giornali delle ultime due settimane di settembre. Le immagini delle migliaia di monaci che sfilano nelle loro tuniche color zafferano con donne e uomini che fanno ala ai cortei tenendosi per mano. Le macchie bianche dei vestiti delle monache. Le bandiere arcobaleno simbolo del Buddismo, l’immensa folla di centinaia di migliaia di persone che manifestano il loro sdegno nei confronti del regime. L’atmosfera festosa dei primi giorni della protesta, quando ancora i militari non si facevano vedere troppo per le strade e sembrava che tutto potesse procedere in una dimensione pacifica e civile.
E poi la tragedia, la violenza, la strage. Un copione che su scala numericamente molto più ampia avevamo già visto nei giorni della primavera cinese a Tien Anmen. I militari scatenati che picchiano, sparano, bastonano, uccidono. Che si avventano sulla gente che fugge, sui monaci che pregano, sulle donne che urlano disperate il loro terrore. E sul giornalista Kenjii Nagai, colpevole solo di esercitare il suo diritto/dovere di cronaca. E infine il buio della censura. Niente più immagini di quanto succede in Birmania. Niente più fotografie, filmati, stampa, video amatoriali dei turisti. L’ordine regna a Rangoon e in tutta la Birmania, è la parola d’ordine dei generali omicidi e nessuno deve permettersi di mettere il naso in cose che non lo riguardano.
E alle critiche della comunità internazionale, delle organizzazioni per i diritti civili (come al solito Amnesty International in prima fila), dei governi, si risponde, come è ormai prassi rituale in occasioni del genere, di non interferire negli affari interni altrui. E comunque, per quanto riguarda i governi, si è trattato -ça va sans dire- di reazioni di facciata, di sdegni formali, di rimproveri che lasceranno il tempo che trovano. Sì, certo oggi è il momento delle critiche, dei richiami, degli inviati dell’ONU che, come ha fatto in questi giorni Ibrahim Gambari, si recano in Birmania, incontrano Aung San Suu Kyi e rimbrottano Than Shwe per quanto successo. Ma sono solo parole. E’ un film già visto tante altre volte, per esempio a TienAnMen. E ai giorni dello sdegno seguiranno ben presto quelli della real politik, degli affari, degli imperativi economici, del “tanto se non commerciamo noi lo faranno altri”. Un copione già letto, appunto. Parlavamo dell’inviato dell’ONU. Ma cosa avrebbe potuto fare il povero Ibrahim Gambari, quando i generali birmani sapevano benissimo che parlava a nome dell’ONU. L’ONU! Quel sepolcro imbiancato che in tutta la sua lunga e dispendiosa vita non è stato mai in grado di fermare una guerra, un massacro, un genocidio (Do you remember Ruanda?). L’ONU, nel cui consiglio di sicurezza siede un modello di democrazia come la Repubblica Popolare Cinese (e che infatti, insieme a quell’altro bell’esempio di democrazia rappresentato dalla Russia di Putin, ha impedito che passasse una risoluzione in cui erano previste sanzioni nei confronti della giunta militare birmana). L’ONU, che qualche tempo fa ha affidato alla Libia la direzione della annuale (e assolutamente inutile) sessione sui Diritti Umani. L’ONU, che cancella Cuba dalla lista delle nazioni censurabili sotto il profilo del rispetto dei diritti umani e ci inserisce Israele.
Cosa volete che voglia fare l’ONU per le migliaia di monaci birmani arrestati e incarcerati in campi di prigionia. Per i monaci che stanno fuggendo dalle città e dai monasteri per cercare di sottrarsi al maglio repressivo dei 400.000 soldati impegnati in una capillare opera di rastrellamento e repressione. Il borioso Than Shwe e la sua accolita di militari violenti, rapaci e stolidi, sa di essere indispensabile alla Cina comunista che ha trovato nella Birmania l’agognato sbocco sull’Oceano indiano e un’enorme riserva di legname a poco prezzo con cui sfamare gli inesauribili bisogni del suo “miracolo economico”. E l’India non è da meno dipendendo abbondantemente dal gas birmano. E poi a seguire tutti coloro, governi e multinazionali, che sono in affari con il regime di Myanmar.
Sì certo, i leader cinesi hanno chiesto, bontà loro, a Than Shwe e alla sua gang, di non esagerare, di essere misericordiosi. E il buon generale, ubbidendo, ha dichiarato di essere pronto ad incontrare Aung San Suu Kyi. A patto però, che quest’ultima “abbandoni il suo atteggiamento di contrapposizione”. Se non ci fossero di mezzo tutti questi morti e tutte queste sofferenze ci sarebbe di che ridere. Del resto Pechino non sta ripetendo da anni a destra e a manca che è pronto ad incontrare il Dalai Lama a patto che questi rinunci a tutte le sue richieste?
Insomma, povera Birmania, povera Aung San Suu Kyi, poveri monaci e monache, povere donne e poveri uomini della sfortunata Repubblica di Myanmar. A voi, come a tanti altri popoli oppressi (penso ai tibetani innanzitutto ma non solo) non resta altro che comprendere di poter contare unicamente sulle vostre forze e sull’impegno e sul lavoro di quelle organizzazioni private che realmente hanno a cuore la vostra sorte. Sono piccole, sono poche, sono povere ma vi sono davvero vicine. E se un aiuto vi potrà arrivare dall’esterno sarà da questa direzione che giungerà. Per quanto riguarda l’ONU e i governi, dimenticateli. Per quanto li concerne, meglio ricordarsi invece il buon vecchio Dante Alighieri: “lasciate ogni speranza o voi che entrate…