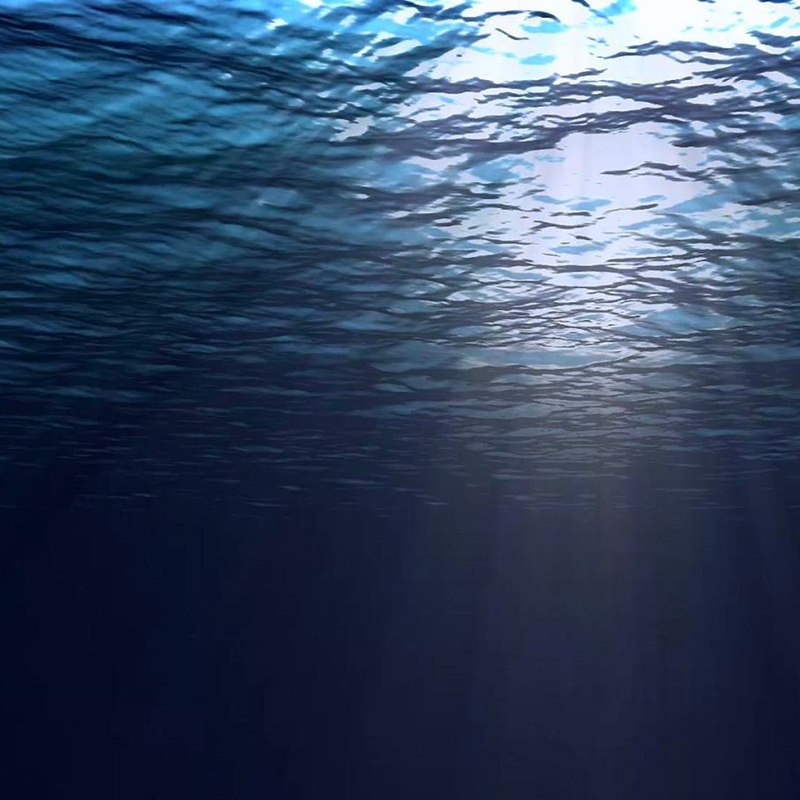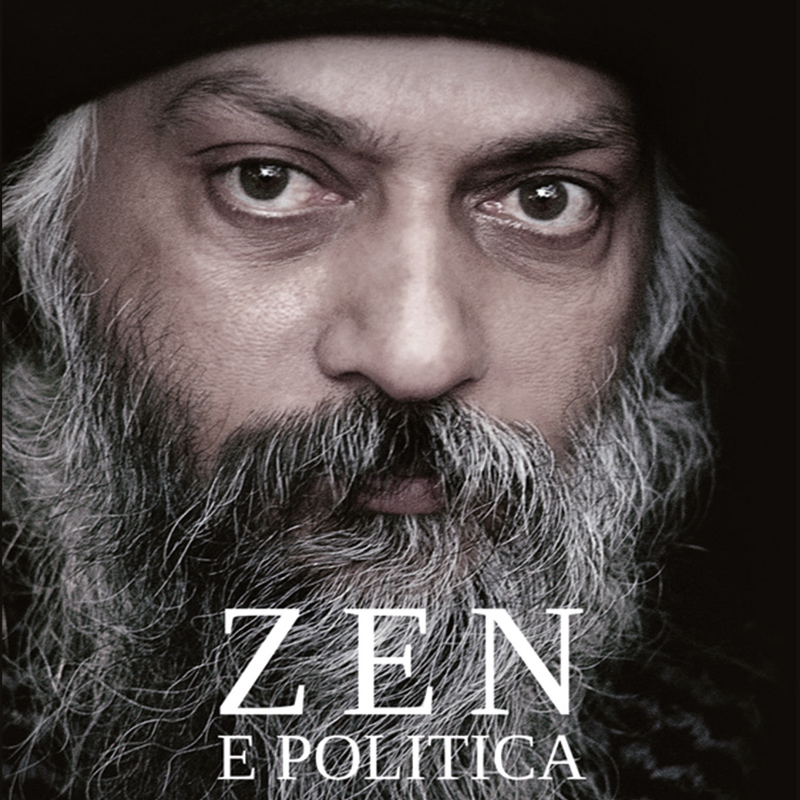In acqua non c’è più aria
di Anna Molinari
Non è un gioco di parole, l’oceano sta soffocando. Dalla metà del secolo scorso a oggi le zone oceaniche senza ossigeno, inclusi mari ed estuari, hanno aumentato di ben quattro volte la loro estensione e le aree con una concentrazione molto bassa hanno decuplicato le dimensioni. Il dato, come molte informazioni importanti per il nostro futuro che non hanno ricadute immediate, passa sotto silenzio, o quasi. Ne parlano gli amici di Slow Food, ne parlano gli addetti ai lavori, ma che in mare non ci sia più aria a gran parte dell’informazione mainstream interessa poco. Che vuoi che sia, non si vede, quindi non sarà poi così grave.
E invece dovremmo preoccuparcene. Perché il calo di ossigeno nelle acque degli oceani è tra le peggiori conseguenze provocate dalle attività umane a danno dell’ecosistema terrestre. La maggior parte degli abitanti del mare non sopravvive senza ossigeno, funziona come per noi, no? E’ una constatazione banale se vogliamo, ma con ricadute che, in una parola, si chiamano: estinzione. Delle creature che vivono in acqua, ma anche degli esseri umani che dalla loro esistenza dipendono. Come infatti riporta anche Repubblica.it, avendo come fonte lo studio realizzato da GO2NE (Global Ocean Oxygen Network), un gruppo di lavoro creato nel 2016 dalla Commissione Oceanografia Intergovernativa delle Nazioni Unite, gli oceani nutrono oltre 500 milioni di persone e danno lavoro a più di 350 milioni, soprattutto per quanto riguarda i Paesi in via di sviluppo. Attività minori legate alla pesca, all’artigianato costiero e al turismo, se il trend rimane questo, saranno le prime a subire il danno a causa delle difficoltà a ricollocarsi altrove, senza considerare il grave impatto che questo causerebbe sull’economia locale.
E’ Denise Breitburg, ricercatrice statunitense in seno allo Smithsonian Environmental Research Center, a rendere noti i risultati di un recente studio (gennaio 2018) che non lascia presagire nulla di buono, anzi. E lancia un grave allarme: dalle coste degli States a quelle europee, da quelle asiatiche a quelle australiane la situazione è preoccupante e lo è a maggior ragione proprio per le dimensioni globali dell’analisi. Sono 500 le zone prive di ossigeno, e non più di settant’anni fa erano 50. Un aumento vertiginoso in un tempo minimo. Non siamo senza speranza, perché il trend potrebbe essere rallentato, se non frenato. Basterebbe una forte volontà politica, oltre che un buon impegno della società civile. Insomma, l’ossigeno se lo mangiano gli agenti inquinanti riversati in mare, e sappiamo bene a quali responsabili si risale partendo da questi presupposti.
Dai combustibili fossili agli allevamenti intensivi, dalle produzioni agricole industriali alle grandi fabbriche, pesticidi, fertilizzanti, concimi, liquami e scarti riempiono le acque di residui di azoto e frammenti inquinanti, tra cui ovviamente anche particelle di plastica. L’espansione di zone a bassa densità di ossigeno provoca l’aumento della produzione di protossido di azoto (N2O), un potente gas serra; riduce la biodiversità; altera la struttura delle reti alimentari; causa l’aumento delle alghe, che “drenano” l’ossigeno rimasto; ha effetti negativi sulla sicurezza alimentare e sulla vita stessa delle persone. Inoltre, il surriscaldamento degli oceani accelera il metabolismo di organismi che, proprio a causa della maggior necessità di ossigeno, ne riducono la concentrazione, mandando a morte, nel vero senso della parola, aree molto ampie.
Sia l’acidificazione che l’aumento della temperatura dell’acqua (che impedisce all’ossigeno di raggiungere le profondità marine) sono meccanicamente legate al processo di de-ossigenzazzione e si combinano con livelli di ossigeno molto bassi intaccando processi biogeochimici, fisiologici ed ecologici. Anche se, va detto, un paradosso da questa analisi emerge: nelle aree costiere non è infrequente che siano proprio le prolifiche industrie per la produzione ittica ad avere responsabilità notevoli su questo versante.
In aree cosiddette “morte” (come ad esempio la Chesapeake Bay e il Golfo del Messico), l’ossigeno è talmente poco che gli animali soffocano e muoiono. Escludendo queste zone, gli habitat naturali di molte creature marine si riducono notevolmente, rendendole più vulnerabili a predatori e pescatori. Un problema che non può essere trascurato anche in aree dove l’ossigeno non manca del tutto ma è presente in quantità molto basse, insufficienti a garantire condizioni adeguate per la crescita e la riproduzione, effetti che poi inevitabilmente si ripercuotono sulla sopravvivenza stessa della specie.
La ricerca, in collaborazione con Unesco, mette graficamente in luce il serio pericolo che stiamo ignorando, anche sulle nostre coste: dal Mar Baltico al Mar Nero i microbi proliferano in mancanza di ossigeno. Prima però che tra le onde, oltre all’ossigeno, venga inghiottito quel poco senno che ci rimane, pensiamoci. Tre sono i fronti suggeriti su cui è necessario agire tempestivamente: affrontare le cause di questo declino, in termini di inquinamento (migliorando i sistemi di depurazione) e surriscaldamento (diminuendo le emissioni di gas serra); proteggere la vulnerabilità dell’ecosistema marino e della sua fauna (ponendo aree importanti sotto tutela ambientale); migliorare la tracciabilità delle aree a bassa densità di ossigeno (individuando così le aree più a rischio per applicare soluzioni calibrate ed efficaci).
Insomma, in fondo sappiamo cosa occorre fare e chi occorre supportare quando abbiamo l’occasione di sostenere come cittadini programmi politici o azioni: dobbiamo privilegiare sistemi di produzione a basso impatto, che non percorrano irresponsabili scorciatoie chimiche le cui conseguenze – non tra molto tempo e non solo per la nostra specie – piomberanno sul futuro del pianeta, condizionandone la sopravvivenza stessa.