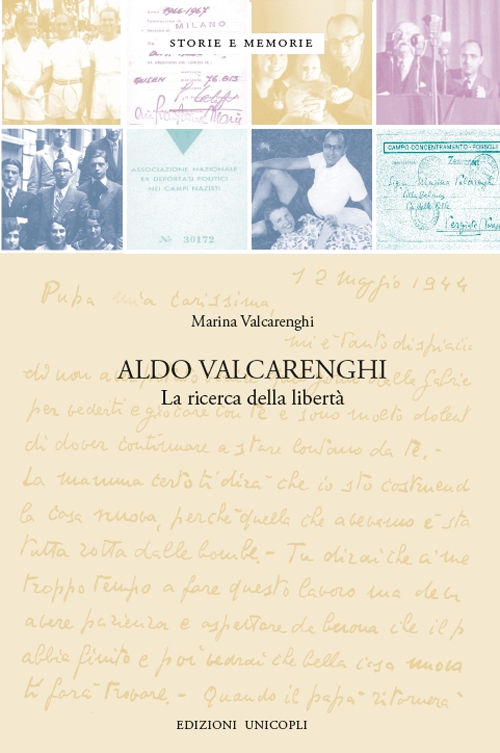Gaber, la straordinaria e dolente umanità
di Antonio Priolo
Qualcuno mi ha suggerito: ma perché non guardare a Giorgio con un taglio prospettico “speranzoso”? Perchè in fondo quello che nell’evidenza della sua opera balza all’attenzione è il suo pessimismo, sull’esistenza e sull’uomo.
E come si può essere uomini straordinari senza innestare uno sviluppo positivo, di conversione laica, sulle macerie che così chiaramente ha disegnato e che lui stesso ha contribuito a produrre radendo al suolo un edificio costruito nell’intimità di ognuno di noi? Come spiegare ad un adolescente la extra-ordinarietà artistica e umana di Gaber se seguendo le sue tracce si rischia di comprenderne solamente una deriva esistenzialista?
Giorgio è stato per molti solo una parentesi di raccoglimento per un tratto del secondo novecento o potremo sentire a lungo i riverberi del suo suono, del suo calore, del suo pensiero? Se andiamo a cercare tra le parole il senso profondo di un metodo, di un modo di accostarsi all’esistenza che ha provenienza antica, rigorosa, disciplinata dalla frequentazione del dubbio e dell’analisi, troveremo i segni di una grandezza che ha segni distintivi in chi ne ha raccolto, in qualche modo, il testimone spirituale?
L’impresa di radicale smantellamento di luoghi comuni e sottili o macroscopiche ipocrisie, che abbiamo osservato quasi esclusivamente con i suoi occhi, è stata già in gran parte analizzata anche se mai abbastanza valorizzata nella sua essenza. Nelle sue canzoni, nel suo teatro così denso di humor e di angoscia abbiamo incontrato la nostra dannazione e le nostre miserie, con l’invito pressante a guardarci dentro. Tanti di noi hanno accolto l’invito ignorando però l’aspetto più significativo della sua opera, che fa di Gaber una personalità che lo eleva dal deserto intellettualistico e politicante della sua epoca.
Il procedimento. Il dubbio, l’analisi e la confutazione. Nulla di nuovo, metodo socratico e di lunga carriera filosofica nel quale però Giorgio ha acceso una scintilla tutta sua, propria del suo tempo e della sua natura, utilizzando il materiale umano, sociale e politico offerto dalle vicende di un quarantennio di carriera artistica. Il procedimento e l’Arte. E l’arte al servizio dell’etica, e l’etica rappresentazione pratica espressa in forma e linguaggio attuali che trasforma le nostre azioni.
Tutto questo è accaduto, e abbiamo vissuto, in un momento di trasformazione profonda, di crisi epocale nella quale siamo ancora avviluppati, di confusione e disperata ricerca di valori, di segni, di messaggi. Dalla scomparsa di dio alla comparsa di orrori succedanei, fino alle brevi meschinità quotidiane di relazioni abusate di vuoto, di abitudini immerse nel dolore, di famiglie “ariose e stimolanti come camere a gas”, con l’arte che ha prestato la voce alle viscere inquiete del malessere della società, una società di individui, di anime e corpi dolenti, malinconici della loro malcelata imperfezione.
“Nel secolo che sta morendo si inventano demagogie e questa confusione è il mondo delle idee. A questo punto si può anche immaginare che potrebbe dire o reinventare un Cartesio nuovo e un po’ ribelle, un mare di parole, un mare di parole, io penso dunque sono… un imbecille”. E pensare che c’era il pensiero.
Che Giorgio ha immaginato come risorsa ultima dell’uomo perso nell’oceano di parole prive di senso e mancante della consapevolezza di ogni azione espressa. Il pensiero come estrema locazione della salvezza dall’imbecillità e dalle trappole di identità disperse e sconosciute.
Il pensiero e la costruzione di un linguaggio che lo renda accessibile, l’irresistibile ironia che ne svela le trame e ne demolisce le fondamenta decrepite, lasciando un deserto di macerie da ricostruire ad un uomo che non sarà più solo se impara a a coltivare l’esercizio del pensiero liberato, la prerogativa della non appartenenza. L’uomo che destruttura le relazioni inaridite e ne coglie la bellezza della rinascita, del senso della vita e dell’impegno nell’affrontare il Dilemma. Il dilemma simbolo della sua visione del rapporto d’amore tra esseri incompiuti che apprendono e accettano le verità della loro malinconica solitudine. L’impegno della conoscenza, della verità, del sapere accogliere il dolore dell’altro. Perchè Giorgio non era per niente un nichilista. “…potremmo di nuovo guardare il futuro e riparlare del mondo non più come condanna ma cominciando da noi, un uomo e una donna.”
Giorgio Gaber uomo straordinario lo era nel criterio adottato per leggere il mondo che intorno a lui si intossicava dei veleni autoprodotti, la sistematicità brutale e sincera con la quale imponeva, prima di tutto a sé stesso, il gioco di specchi che aprivano lo sguardo prima ironico, poi in un crescendo di smarrita e spietata crudezza, alla dolente vacuità dei nostri umanissimi atti, alla nudità dell’uomo, del suo corpo e della sua anima devastata.
E uomo straordinario lo era, non secondariamente, per la sua pervasiva umanità, generosità, attenzione, amore per il vivere consapevole. La sua esigenza primaria di lottare contro la superficialità, che si tradusse anche nella fortissima volontà di rilanciare questa rivista quale luogo per incontri più profondi tra anime libere e ricercatori dell’inesplorato, lo rendeva sensibile ad ogni nuova forma di espressione che si affacciava nello scenario artistico e sociale. Salvo poi ritrarsi amareggiato nella constatazione che i vecchi vizi e la manifestazione di nuove false virtù rendevano il nuovo sovrapposto, nella sostanza, a ciò che pretendeva di sostituire se non rivoluzionare.
Forse un Gaber incompiuto, nel suo progetto artistico, dalla sospensione dovuta alla malattia, alla preparazione interiore di un percorso che volge al termine. Già tanti anni prima Giorgio aveva ragionato con noi del morire, nel 1995 aveva aderito, col suo solito entusiasmo quando si trattava di cose che avevano il sapore di “Re Nudo”, lui allergico per eccellenza alla partecipazione a convegni e al fiume di parole inutili che si perdono in queste sedi, al Convegno sulla Coscienza della Morte, a modo suo, con un appassionato monologo sul tema. Ma un incompiuto temporale, una frattura della produzione artistica che non aveva interrotto il suo febbrile scrutare dell’umana fragilità, il pietoso e a volte rabbioso sentimento che nutriva per la vita e per tutte le sue rappresentazioni.
Con l’umiltà del vero ricercatore, di chi non trova il senso ultimo e di questo si è posto, con intima vulnerabilità ed esposizione, il progetto finale. Un ricordo. Nell’inverno del 2000 con Majid accompagnammo Giorgio nel carcere di Pisa, dove allora era detenuto Adriano Sofri, per un incontro tra questi due artisti (ognuno per la sua sapienza) del pensiero. Nel tragitto in auto dalla sua casa in Lucchesia, scendendo giù verso Pisa, col buio precoce della pioggia e della nebbia che aveva oscurato tutt’intorno, Giorgio aveva voglia di parlare con noi ma soprattutto aveva voglia di capire, da persone diverse da lui, del senso profondo di ciò che accadeva all’umanità, ponendo domande precise e, nel mio ricordo, vertiginose.
Fino alla fine non ha mai smesso di dubitare, di scoprire, di rompere e di cercare di aggiustare, quello che fa un uomo straordinario cui è stato concesso il privilegio ed il talento per farlo.
Ci risiamo: Giogio Gaber sbeffeggia i luoghi comuni della vita, dell’amore, della politica con ironia serissima e impegnato disincanto e il mondo della cultura si spacca nei soliti poli contrapposti dei pro e degli anti Gaber. L’artista viene attaccato sopratutto da chi non si riconosce nella sconfitta della “sua generazione”, da una parte del popolo della sua sinistra di cui, per amore deluso, non si stanca di raccontarci i vizi, i conformismi e le debolezze, ma anche gli slanci e la generosità; attaccato da chi ha la certezza di trovarsi nel luogo giusto, luogo che altri stanno ancora cercando per sentirsi “parte” non solo di una storia abusata ma di un progetto in divenire.
Questo signore sessantenne sempre di scuro vestito, che ostenta una claudicatio che non spegne i piroettare della sua figura, che ricorda un borghese illuminista milanese, è “naturalmente” un provocatore, uno che provoca dibattito. È un estremista del dubbio e della ricerca, il più antintellettuale degli intellettuali perché ha saputo parlare di grandi ideali, di sconfitte e di speranze attraverso i corpi (il suo soprattutto), le malattie, le camere da letto disfatte, oscure e senza gioia.
E una speranza s’accende a vederlo così in alto nella classifica delle vendite di dischi o guardarlo cantare da Celentano “Quando sarò capace d’amare” e immagini milioni di fiati sospesi dalla crudezza e dalla dolcezza, una sospensione e un sussulto, “quando sarò capace di amare mi piacerebbe un amore che non avesse alcun appuntamento col dovere”. Si accende la speranza che finalmente, piaccia o non piaccia quello che canta, si torni al pensiero.. ma forse è solo un incidente di percorso e tutto tornerà come prima. Speriamo di no, per noi e per lui.